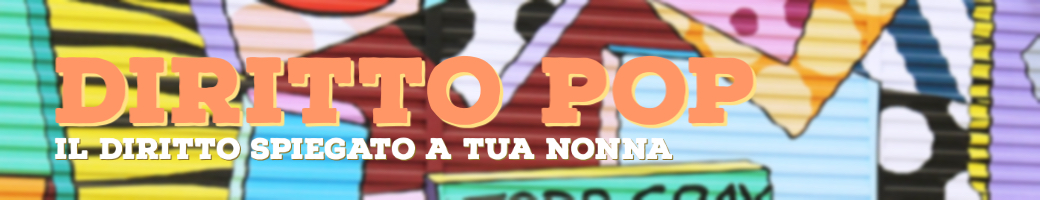Il termine sciopero deriva dal verbo latino exoperare «smettere di lavorare.
Come lo conosciamo oggi, lo sciopero è l’astensione collettiva dal lavoro da parte dei lavoratori che rivendicano determinate richieste (ad es., l’aumento della retribuzione) o diritti ed è, quindi, lo strumento tipico di lotta sindacale.
Lo sciopero, o meglio il diritto di sciopero, è previsto anche nell’articolo 40 della Costituzione, che stabilisce che esso si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano (ndr: vedremo meglio dopo cosa significa)
Ma esattamente quando è nato lo sciopero?
La nascita dello sciopero
Di sciopero si parla già in un papiro, chiamato appunto “papiro dello sciopero” datato 1187-1157 a.C. e conservato presso il Museo Egizio di Torino, in cui si legge:
“Sono già trascorsi 18 giorni in questo mese: e (gli uomini) andarono a sedersi nel retro del tempio (…) Se siamo arrivati a tanto, è stato a causa della fame e della sete (…) Scrivete al faraone (…) perché ci siano date le provvisioni“.
Quindi anche i famosi egizi scioperavano! Dovranno passare quasi 3.000 anni, però, per arrivare ad un’idea più moderna di sciopero. È infatti con la Rivoluzione Industriale (XVIII–XIX secolo) che le masse operaie iniziarono ad organizzarsi e diedero vita alle prime azioni collettive contro lo sfruttamento e contro lo condizioni di lavoro durissime.
Per lungo tempo lo sciopero fu visto come atto illecito o addirittura sovversivo e in molti Paesi europei, tra cui l’Italia, era considerato un vero e proprio reato: in Francia fu vietato per legge nel 1791 (Legge Le Chapelier) mentre nel Regno d’Italia, il Codice Zanardelli del 1889 puniva lo sciopero violento o politico, e lo considerava una minaccia all’ordine pubblico.
All’inizio del Novecento, però, lo sciopero diventa una delle principali forme di lotta del movimento operaio e in Italia vi fu il c.d. Biennio Rosso (1919–1920), in cui operai e contadini chiedevano aumenti salariali, riduzioni dell’orario di lavoro e giustizia sociale.
Il fascismo, la cancellazione dello sciopero e la Costituzione
Con l’avvento del regime fascista, ogni forma di sciopero venne abolita. La Legge n. 563/1926 (Leggi fascistissime) vietò esplicitamente le libertà sindacali, sciopero e serrate vennero tassativamente proibite in quanto considerato come atti sovversivi contro lo Stato e le uniche organizzazioni sindacali ammesse erano quelle corporative, controllate dal regime.
Dopo la caduta del fascismo e la fine della guerra, la svolta arrivò con la Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, che volle garantire ai lavoratori i diritti fondamentali negati per decenni
Nonostante il riconoscimento costituzionale, il diritto di sciopero venne regolamentato solo con la legge 146/1990, che regolamentò l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali anche per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori-utenti.
Anche grazie alla legge 146/1990 si riuscì a dare applicazione a quanto previsto dall’art. 40 della Costituzione: il diritto di sciopero, cioè, non può essere esercitato in modo indiscriminato, ma si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano ed è quindi compito del legislatore disciplinarlo.
(Anche) Questo articolo è stato scritto da una persona, non da una macchina!
Questo è Diritto-Pop!